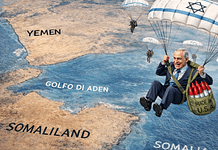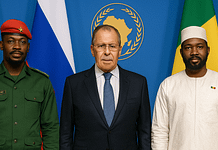A due mesi dall’inizio dei campionati del mondo di calcio, che vedranno i riflettori del pianeta puntati per più di un mese sul paese africano, sembrano essere superate le polemiche relative all’organizzazione. Nel mese di marzo il blocco della produzione della mascotte ufficiale dei campionati del mondo Zakumi (letteralmente “Sudafrica 2010”), imposto dagli incaricati della Global Brands Group per via dello sfruttamento della manodopera impiegata per la sua realizzazione, aveva provocato malumori all’interno del mondo sindacale e nell’opinione pubblica. E anche se può apparire un fatto di cronaca non rilevante, per chi è attento alla geopolitica e alla geoeconomia, invece, assume connotati emblematici. La produzione della mascotte è stata affidata, infatti, alla cinese Shangai Fashion Plastic Products & Gifts, che si è aggiudicata il relativo appalto indetto dalla GBG. Il coro di protesta dei sindacati sudafricani, contrariati per l’affidamento della realizzazione degli oltre due milioni di pupazzi ad un’azienda cinese, merita attenzione, soprattutto perché evidenzia una realtà ormai consolidata, ovvero la partnership tra Pretoria e Pechino.
Prima di concentrarci sui rapporti commerciali e politici Cina-Sudafrica, sembra utile fare un excursus apparentemente avulso dal contesto, ma che rende giustizia al processo analitico dal particolare all’universale, e porta alla luce la doppia dimensione sia della politica interna che della politica internazionale sudafricana.
Nella piana di Makhathini, nel nord della provincia sudafricana dello KwaZulu-Natal, c’è un importante centro operativo della Monsanto Company, il colosso statunitense delle biotecnologie agrarie. Da queste parti il terreno non è molto fertile, e anche se alcuni contadini hanno accesso alle risorse idriche per l’irrigazione, la maggior parte di loro deve combattere l’aridità del suolo e sperare in un aiuto da parte delle sempre più imprevedibili precipitazioni. Per di più gli appezzamenti che superano i dieci ettari sono pochi, dato che rivela lo stato economico assai precario di chi deve fare i conti non solo con le compagnie che garantiscono i fidi per gli investimenti, ma anche con diversi fattori variabili di carattere ambientale e meteorologico. Nella stagione 1998-99 la Monsanto offrì a circa duemila contadini la possibilità di coltivare cotone biotecnologico, garantendo cospicui miglioramenti nella resa e maggiore protezione antiparassitaria. In un’economia debole come quella dell’area qualsiasi miglioramento di tipo quantitativo può essere determinante per la sopravvivenza delle famiglie contadine, così il cotone biotech fu adottato con grandi aspettative di successo. La realtà, però, fu molto diversa da quella auspicata dai coltivatori, soprattutto perché i semi della Monsanto, pur essendo forse più indicati per una coltivazione su terre aride, non sono come il fagiolo magico della celebre fiaba di Richard Walker: essi hanno egualmente bisogno di un’irrigazione sufficiente e di pesticidi. Ma il loro costo elevato e l’inesperienza o l’incoscienza dei contadini hanno fatto sì che le piante non fossero protette, ma piuttosto lasciate alla mercé di ogni tipologia di parassita. Il fallimento a lungo termine di progetti biotecnologici di questo tipo dovrebbe essere messo in conto da ogni buon analista delle politiche agrarie. In questo caso l’analisi del rischio non doveva essere così difficile da fare, e se è vero che gli investimenti e le sperimentazioni fallite toccano principalmente le tasche dei meno abbienti, è vero anche che le statistiche sono fatte da coloro che detengono gli interessi maggiori.
L’esempio particolare di Makhathini ci introduce nella dimensione universale del problema. Ovvero quello dei flussi finanziari internazionali da e verso il continente africano. Negli ultimi sei anni il volume dello scambio tra Sud Africa e Cina ha avuto un’impennata, una crescita che Lucien van der Walt e Michael Schmidt quantificano intorno al 400%, con un incremento nel 2006 del 26% su base annuale, toccando in quello stesso anno i 35 milioni di dollari. Pretoria, capitale della prima economia del continente, è divenuta in questo modo il miglior socio africano di Pechino. Nel 2006, l’ex presidente Mbeki aveva rassicurato chi temeva una nuova colonizzazione, questa volta con gli occhi a mandorla, sostenendo la necessità di scongiurare il pericolo che la forte economia cinese dominasse i Paesi Africani. Di natura diversa sembra infatti l’asse Pechino-Pretoria. I finanziamenti a tassi d’interesse bassissimo concessi a paesi come la Namibia – utili a sbilanciare il rapporto e a favorire l’accesso cinese alle miniere di diamanti, uranio, zinco e cobalto – non occorrono all’economica sudafricana, forte anche di una moneta, il rand, con un buon potere d’acquisto. Quello che interessa ai politici sudafricani è, invece, l’aumento degli investimenti cinesi nei settori già molto industrializzati, dacché essi possono essere d’aiuto per un ulteriore sviluppo e per il ridimensionamento del deficit statale. Le ambizioni di potenza regionale fanno guardare gli imprenditori sudafricani verso i paesi limitrofi, tanto da ipotizzare la possibilità di una vera competizione con le potenze occidentali e con la Cina. In questo senso, dopo l’avvento dei cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), il Sudafrica sarebbe entrato, insieme a Turchia, Indonesia e Messico, a pieno titolo nelle nuove economie emergenti, gli STIM. La recente visita ufficiale del presidente Zuma in Uganda rafforza questa teoria. Il tema dell’africanità, quindi dell’unità politica dei paesi africani, è stato rilanciato con forza a Kampala, e l’intesa con il collega ugandese Yoweri Museveni sembra aprire scenari economici importanti. Sebbene la presenza sudafricana in Uganda non sia cosa nuova – sul territorio ugandese agiscono infatti circa cinquanta aziende sudafricane –, nuova è la sfida imprenditoriale lanciata alle imprese cinesi, che, se è vero che detengono il controllo della gran parte delle risorse petrolifere, lasciano qualche spazio nel settore minerario, da poco rilanciato grazie alle scoperte (ed è un particolare non trascurabile che siano state fatte attraverso le analisi scientifiche sudafricane) di quantità significative di minerali nel sottosuolo ugandese. Si rivela dunque il paradosso sudafricano: la paura di essere colonizzati diventa desiderio di colonizzazione. Non è difficile distinguere la retorica del panafricanismo dalla retorica di mercato. Come non è difficile capire che un paese africano come l’Uganda possa favorire ben più volentieri investimenti di un altro paese africano, che promette il rilancio delle economie continentali, piuttosto che quelli di un colosso mondiale come la Cina, la cui presenza economica (e quindi, inevitabilmente, politica) in terra d’Africa si sta allargando a dismisura. L’esempio di Makhathini e il rinsaldamento dei rapporti commerciali e politici con l’Uganda portano alla luce il paradosso. Da una parte abbiamo una multinazionale statunitense che sperimenta i propri prodotti, offrendoli ai coltivatori locali, riuscendo così (con le relative disastrose conseguenze) a far pressione sull’economia interna; abbiamo anche gli investimenti cinesi nei settori industriali più avanzati, utili a ridurre il deficit e a far crescere la produzione e l’occupazione. Dall’altra c’è lo sguardo sudafricano alle economie dei paesi vicini, la mano degli imprenditori e dei politici di Pretoria, ambiziosi e ormai ampiamente svezzati dal colonialismo. Il pericolo di un “neocolonialismo” interno al continente è un fatto nuovo, che, almeno per il momento, non sembra dare preoccupazione agli altri paesi africani. Resta da capire quali saranno le reazioni cinesi allorché i governi africani cominceranno a preferire partnership con Pretoria, favorendo l’installazione di imprese sudafricane e garantendo vantaggi maggiori in termini contrattuali. Lo stesso presidente ugandese Museveni ha ribadito che il suo paese, in linea con le direttive della Banca Mondiale e del Fmi, garantirà un’economia di mercato liberalizzata, profilando una competizione forse aspra forse concertata tra la Cina e il Sudafrica.
* Roberto Sassi è laureando in Teorie e pratiche dell’antropologia (Università La Sapienza di Roma)
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.