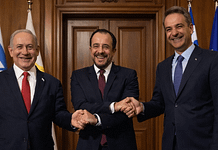di Alessandro Gatti
La questione balcanica negli equilibri dei rapporti tra Nordamerica ed Europa: convergenze e divergenze
Non può dirsi che abbia avuto torto, il politologo statunitense Barry Buzan, nell’affermare che in seguito alla Guerra Fredda è avvenuto un processo di “ridistribuzione dei dividendi della potenza” a favore degli Stati Uniti d’America e dell’Europa “salita sul carro del vincitore”. Il disfacimento dell’Urss, lasciando gli Usa unici arbitri del contesto geopolitico globale, ha comportato quella che il Buzan definisce “unipolarità” del dominio internazionale. Nei fatti questo è vero: dal 1991 il mondo non poteva più dirsi bipolare. L’aspetto problematico era però rappresentato da due fattori, in primo luogo la natura contorta della politica estera americana che, da sempre nella sua storia, ha confuso teorici, esperti, alleati e nemici, oscillando tra isolazionismo e propensione al coinvolgimento negli affari internazionali. In secondo luogo il ruolo che l’Europa avrebbe dovuto giocare nella gestione del nuovo contesto unipolare. Tra il 1992 ed il 2003 la politica estera Usa si alterna lungo tre approcci fortemente distinti l’uno dall’altro: l’approccio da poliziotti del mondo, con cui gli Usa gestiscono gli equilibri mondiali secondo un’ottica unipolare; l’approccio neo-isolazionista; un approccio unilateralista che è una miscela di interventismo, quando conviene, ed isolazionismo. Quanto al ruolo europeo, non è un segreto che da quando lo “spauracchio” del comunismo si affacciò all’orizzonte, dopo la Seconda Guerra Mondiale, preoccupazione primaria degli Usa fu quella di catalizzare verso di loro gli interessi del Vecchio Continente. Non da ultimo, gli Usa si fecero promotori del processo di integrazione europea. Gli Stati Uniti avevano investito molto nell’Europa, sia con il piano Marshall che con i finanziamenti all’Organizzazione per la ricostruzione europea (OECE). Si aspettavano dunque molto dall’Europa in termini di sostegno militare e logistico. Il così detto “Building Sharing (creare le basi per una condivisione)” era un progetto ambizioso che inizialmente gli europei non sembravano né potere ne volere sposare. Nell’ottica statunitense questo approccio avrebbe dovuto vedere catalizzati gli interessi delle due parti, Usa ed Europa, nella cooperazione per la costruzione di una pace istituzionale e politica post Guerra Fredda. Negli anni ’90 gli Stati Uniti si rendono conto che è impensabile una prospettiva meramente isolazionista. L’interesse statunitense ed europeo si sposava in merito alla questione balcanica. Clinton, in quegli anni molto vicino alle sinistre europee, guardava all’Europa come ad una sorta di “segretaria” cui delegare, se non il controllo assoluto, per lo meno la gestione dei focolai nella parte Est del Vecchio Continente. Il vuoto di potere lasciato dal crollo dell’Urss in quella zona aveva innescato una serie di situazioni di instabilità politiche che stavano esplodendo. La criticità dei Balcani rappresentò dunque, negli anni ’90 un occasione di riavvicinamento degli interessi tra Usa ed Europa. Diede da un lato agli Stati Uniti la spinta per uscire dall’ottica dell’isolazionismo totale e dall’altro costrinse l’Europa a smuoversi per non perdere l’occasione dell’appoggio statunitense in una zona particolarmente calda del proprio continente. Il conflitto tra Serbi, Croati e Sloveni esplose, con dei focolai, già attorno al 1980 e si protrasse fino allo smembramento definitivo della Repubblica Socialista Jugoslava tra il 1991 e il 1992. Da questa la Bosnia Erzegovina, la Slovenia, la Serbia e la Croazia acquisirono l’indipendenza. Tra il 1996 ed il 1999, fu la volta della provincia autonoma del Kosovo che perseguì l’indipendenza dalla Serbia di Milosevic’ con un conflitto civile significativo per la grammatica dell’equilibrio internazionale e per l’assetto politico organizzativo della Nato.
Dal “Partenariato per la pace” al vertice di Washington del 1999
Nel disegno originario che diede vita al Patto Atlantico, nel 1949, i rapporti Usa ed Europa si sarebbero dovuti basare su una logica di condivisione e cooperazione. Secondo quest’ultima gli Stati Uniti avrebbero gestito l’arma nucleare e gli europei si sarebbero occupati dell’aspetto prettamente convenzionale. Il clima della deterrenza nucleare che caratterizzò la Guerra Fredda fu il pretesto, da parte dell’Europa, per tenersi fuori dal coinvolgimento nelle faccende internazionali pur mantenendo la garanzia della protezione statunitense. Dopo la Guerra Fredda l’alibi del nucleare non bastava più per sollevare gli europei da quelle che erano le loro responsabilità. Con la fine dell’ Urss cessavano di fatto le logiche della deterrenza e la Nato, si preparava a riconfigurarsi secondo nuove grammatiche; dandosi nuovi obiettivi e rinnovando i suoi scopi al fine di trovare ancora una ragion d’essere. A questo proposito vediamo il modello di allargamento verso l’Europa dell’Est, il così detto “Partenariato per la pace” (pfp), con il quale, a partire dal 1994, per sfruttare una fortunata espressione di Ikemberry, gli Stati Uniti consolidarono il “costrutto istituzionale del dopo Guerra Fredda”. Pfp è stato il punto di maturazione di un percorso di riconfigurazione degli scopi Nato iniziato nel 1991, con il vertice di Roma. Il passo successivo, quello del nuovo concetto strategico Nato scaturito dal vertice di Washington del 1999, sotto l’amministrazione Clinton, consisterà nell’applicazione del modello Clinton-Albright alle operazioni militari nella campagna in Kosovo. In seguito alla decisione, assunta con il vertice di Roma del 1991, di ricercare un nuovo scopo per la Nato nell’allargamento ad Est, bisognava impegnarsi a fare in modo che a tale espansione, di influenza ed estensione per l’Alleanza, corrispondesse un effettiva e tangibile stabilizzazione e securizzazione di quello che rimaneva della vecchia Urss. Il modello Clinton-Albright puntava infatti ad intendere l’allargamento ad Est della Nato come un’opzione strategica di proiezione della sicurezza a cui tutta l’Europa avrebbe dovuto partecipare. Se prima del 1991 la minaccia per la sicurezza era rappresentata dal diffondersi del comunismo, ora era rappresentata dal vuoto che questo aveva lasciato. Il problema della proliferazione del nucleare fra stati senza compattezza politico-istituzionale ed il vuoto di governabilità che aveva causato l’esplodere di tumulti e disordini civili in tutti i territori dell’Europa dell’Est erano il nuovo pericolo. La Nato, come organo sovranazionale, sintesi del principio democratico dei suoi Stati membri, doveva gestirlo. Su questo scenario l’Europa occidentale era chiamata ad un ruolo di protagonista affianco degli Usa e doveva intendere se stessa non solo come l’insieme degli Stati europei, ma come l’insieme delle istituzioni europee. Alla base del modello Clinton-Albright vi era una visione di stabilizzazione e “strutturazione della pace” di lungo periodo, economicamente e operativamente sostenuta da tutti gli Stati membri della coalizione.
L’approccio innovativo della Nato alla guerra in Kosovo e la sperimentazione della “Nuova Rivoluzione nelle pratiche militari”
I conflitti nei Balcani rappresentano un primo banco di prova per esaminare, a livello pratico ed operativo, le potenzialità della nuova Nato. Se quest’ultima era stata principalmente un’alleanza statica, sotto la Guerra Fredda, doveva ora divenire più dinamica ed abbracciare ambiti strettamente correlati a quello militare, se pur non specificatamente di natura belligerante. L’Alleanza Atlantica diveniva anche un catalizzatore della cooperazione Usa-Europa, anticipando quello che passerà alla storia, negli anni futuri, come il “Nuovo accordo Transatlantico”, e cioè un rinnovato approccio di collaborazione fra Vecchio Continente e Stati Uniti. La sinergia operativa e mentale che permetterà l’efficacia delle future operazioni in Afghanistan, nella lotta al terrorismo, non avrebbe mai trovato esito se non si avesse avuto il test della coalizione Nord Atlantica nella gestione della crisi balcanica. La Guerra Fredda ebbe l’effetto di ripristinare, nell’Europa dell’Est la stessa condizione di precarietà socio-politica antecedente le due guerre mondiali. Il “Partenariato per la pace” consentì alle forze Nato di avviare l’operazione “Forza di liberazione volontaria” contro i serbo-bosniaci e il conseguente accordo di Dayton che, stabilizzando la crisi in Bosnia Erzegovina, creava di fatto due entità distinte ed autonome: la Federazione croato-musulmana e la Repubblica serba. Da qui si arriverà presto al colpo di mano del Presidente serbo Milosevic che toglierà agli albanesi del Kosovo il riconosciuto diritto d’autonomia ed identità culturale previsto dallo statuto. Di qui il ruolo della Nato sarà quello di avviare l’operazione “Forza alleata”. Senza aver ricevuto l’avallo dell’ONU e, quindi senza legittimazione alcuna, da parte delle Nazioni Unite, “Forza Alleata” bombarderà Belgrado e le forze serbe in Kosovo per settantotto giorni. A quest’operazione, che non si può non definire sanguinaria, faceva seguito “Joint Guardian”, che inviava la “Forza di liberazione per il Kossovo” con il compito di garantire aiuti economici, assistenza sanitaria e sicurezza a tutti gli abitanti. Su quest’ultimo punto si spiega l’importanza dell’innovazione che il modello Clinton-Albright aveva apportato alla nuova Nato. Questa era ora una alleanza di stati combattenti votata alla soluzione di conflitti internazionali, ma anche un’organizzazione in grado di garantire supporto e stabilizzazione con operazioni di “edificazione della pace” e “strutturazione istituzionale”. Al di là delle critiche e delle polemiche, alcune delle quali più che giuste, che verranno formulate nei confronti delle successive guerre in Iraq e in Afghanistan, la situazione balcanica rappresenta un preludio e un’anticipazione della più matura evoluzione della guerra nell’approccio di tattica militare definito “a tre blocchi”. Quest’ultimo consisterà, nelle guerre in Iraq e in Afghanistan, nella fusione di un approccio belligerante, di tipo “colpisci e terrorizza”, seguito da operazioni di pattugliamento, azioni umanitarie, di assistenza e ricostruzione. Questi aspetti saranno, per quel che riguarda la situazione balcanica, il punto nevralgico delle operazioni del 2001 “Volpe d’ambra” e “Armonia Alleata”. La guerra in Kosovo ha rappresentato, tra le altre cose, quella che è stata definita, in ambito militare, come Rivoluzione nelle pratiche militari (RMA secondo l’acronimo anglosassone). Secondo questa visione il conflitto avrebbe dovuto ridurre al minimo le perdite umane, sia tra soldati che civili, per concentrare attacchi massicci, con bombe intelligenti e teleguidate ad elevata capacità distruttiva, sui soli obiettivi ritenuti strategici. Questi attacchi mirati sarebbero stati sapientemente predisposti dopo operazioni di ricognizione condotte da aerei senza pilota (tecnologie U.A.V: “Tecnologie aeree senza pilota”). Le operazioni Nato nei Balcani vollero essere un test per dimostrare e provare l’efficienza di una nuova Alleanza per la pace. Il Kosovo fu il teatro di un nuovo modo di combattere, volto a ridurre al minimo le perdite e ad accorciare i tempi nel raggiungimento di obiettivi politici concreti col minimo danno: umano e psicologico. Il Kosovo segna un punto di svolta nei rapporti Usa- Europa ed un rivoluzionario approccio al modo di combattere che persegue il rispetto del principio clausewitziano e suntzuniano di una guerra, non fine a se stessa, ma orientata al necessario ottenimento di un risultato con una ragionevole economia delle perdite.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.