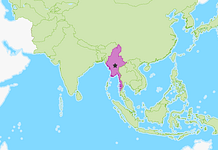Nel momento in cui la Commissione Elettorale del Pakistan inizia a rilasciare i risultati finali della tornata elettorale di venerdì 8 febbraio, si possono trarre alcune conclusioni ed ipotizzare quello che sarà il futuro del gigante demografico dell’Asia Meridionale nel contesto della transizione verso un ordine globale multipolare e dell’attuale “guerra mondiale a pezzi” che vede impegnate diverse forze eurasiatiche (Russia, Iran e Cina, in primo luogo) contro la “geopolitica del caos” dell’Occidente a guida nordamericana.
Anche in Italia, dove la conoscenza della storia del Pakistan è assai limitata benché l’immigrazione pakistana sia in costante aumento, quando si parla di questo Paese si rischia di cadere nel pregiudizio ideologico (prodotto di certa pubblicistica nordamericana e dei gruppi di pressione filoindiani) che cerca di presentarlo come “Stato fallito”, ostaggio di gruppi religiosi fondamentalisti e/o dei sempre presenti militari. Non solo. Periodicamente, si evoca anche il rischio che tali “gruppi fondamentalisti” si approprino dell’atomica pakistana; ma non viene mai chiarito in che modo, visto che il sistema di controllo e supervisione delle armi nucleari pakistane è piuttosto complesso.
Ad onor del vero, come aveva già osservato lo storico e giornalista pakistano-britannico Tariq Ali nel suo lavoro The duel: Pakistan on the flight path of the American Power (Simon & Schuster, Londra 2008), è assai più probabile che la non dichiarata atomica israeliana finisca nelle mani di gruppi religiosi fondamentalisti dalle aspirazioni messianiche (non a caso, l’attuale Ministro israeliano del Patrimonio Culturale Amichai Eliyahu ha suggerito a più riprese l’idea di sganciare una bomba atomica su Gaza)[1]. Così come è assai più probabile che i gruppi fondamentalisti indù al potere a Nuova Delhi (lo stesso Narendra Modi da governatore del Gujarat si rese artefice di veri e propri pogrom contro la popolazione musulmana) finiscano in possesso delle chiavi del sistema di difesa nucleare dell’India. Ma lo Stato subcontinentale, in stretti rapporti con Israele (l’esclusivismo etno-religioso anti-islamico è marchio di fabbrica dei teorici dell‘hindutva così come di quelli del sionismo religioso-revisionista), continua ad avere un ruolo di primo piano nei progetti nordamericani di contenimento della Cina. Addirittura, tra gli strateghi nordamericani c’è chi pensa all’India (la cui Costituzione ricalca quella statunitense) come “sostituto” degli USA, quando questi avranno esaurito la loro spinta egemonica.
Detto ciò, si rende necessario affrontare l’altra accusa che solitamente si rivolge al Pakistan: quella di “Stato fallito”. Anche in questo caso, la realtà è assai più complessa di come viene descritta. È sicuramente un dato di fatto che i militari (ed in particolare l’attuale Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Syed Asim Munir), a prescindere da qualsiasi esito elettorale abbiano un potere quasi illimitato – per fare un esempio, nelle ambasciate pakistane in giro per il mondo l’addetto militare ha un ruolo pari se non superiore a quelli propriamente diplomatici – ed è altrettanto vero che il Pakistan ha difficoltà economiche evidenti, specialmente se si considera la disparità tra le diverse aree che compongono la Repubblica. Tuttavia, esistono innegabili fattori storico-politici che non possono essere tralasciati quando si affronta uno studio onnicomprensivo della realtà pakistana. Nello specifico, esistono tre “relazioni” che hanno storicamente contraddistinto l’evoluzione politica del Pakistan: quella tra Popolo e Stato (o meglio, tra classi popolari ed una élite politica in larga parte composta da un’aristocrazia terriera, e successivamente industriale, erede diretta del Raj britannico); quella tra Stato e Islam (il padre fondatore del Pakistan Muhammad Ali Jinnah lo aveva pensato come uno “Stato islamico”, espressione foriera di enormi contraddizioni); quella tra Stato ed Esercito (anch’essa in qualche modo eredità del colonialismo, visto che furono i Britannici ad utilizzare in larga maggioranza l’etnia punjabi – ancora oggi preponderante nell’esercito – come “forza di sicurezza”).
Ora, la prima elezione di Imran Khan nel 2018 si poneva in netto contrasto con la tradizionale formula politica pakistana che vedeva poche famiglie (Bhutto, Sharif, Zardari) alternarsi al potere in periodi di dittatura militare da più di cinquant’anni. A questo segno di rottura con i vincoli semifeudali del passato si aggiungeva il fatto che l’ideologia politica del Partito di Khan (il Tehreek-e-Insaf, Movimento per la Giustizia del Pakistan) si presentava come una commistione tra giustizia sociale (pur con ampi margini di manovra per l’iniziativa privata) e slanci religiosi impregnati di misticismo sufi. Volendo tentare un paragone, sebbene con le dovute differenze date dal contesto, la progettualità politica del Tehreek-e-Insaf non è così diversa da quella rappresentata in ambito esclusivamente amministrativo da Hamas a Gaza o dall’AKP in Turchia.
Prescindendo da ciò, il reale motivo alla base della defenestrazione di Imran Khan è stata la postura geopolitica che ha cercato di dare al suo governo. A questo proposito, molti analisti si sono concentrati in primo luogo sul rapporto sempre più stretto tra Pakistan e Repubblica Popolare Cinese. In realtà, questa “relazione speciale” esiste da decenni. Non è un prodotto dell’esperienza governativa di Imran Khan (la scelta di partecipare da protagonista alla Nuova Via della Seta appartiene al precedente governo di Nawaz Sharif) ed è databile addirittura agli anni ’60 del secolo scorso, quando Zulfiqar Ali Bhutto teorizzò per il Pakistan un ruolo equidistante nel contesto bipolare attraverso il rafforzamento delle relazioni diplomatiche con Pechino. Da quel momento in poi, i rapporti tra Cina e Pakistan (rafforzati anche dalla cooperazione nucleare) hanno conosciuto una crescita continua, quasi inarrestabile, nonostante i tentativi di diversi gruppi terroristici di sabotare le infrastrutture del Corridoio Economico Sino-Pakistano, tanto che oggi c’è chi ipotizza per il Pakistan un futuro da “Messico della Cina”.
Questo aspetto è abbastanza rilevante se si prendono in considerazione i recenti attacchi iraniani (in risposta alla strage di Kerman) a quei gruppi terroristici che operano sul lato pakistano del Baluchistan in stretta cooperazione con CIA e Mossad. Ovviamente, c’è chi ha cercato di sfruttare la cosa per scatenare delle frizioni diplomatiche tra Islamabad e Teheran. Tuttavia, non è da escludere che le azioni iraniane siano avvenute con il tacito consenso sia di Pechino sia dello stesso ISI, i servizi segreti militari pakistani da tempo impegnati nella lotta contro i movimenti secessionisti dell’area. L’eliminazione di questa minaccia, inoltre, rappresenta per Pechino una garanzia di sicurezza su un progetto infrastrutturale ed energetico necessario (insieme alle connessioni siberiane con la Russia) per aggirare l’eventuale chiusura dello stretto di Malacca in caso di conflitto nel Mare Cinese Meridionale e nell’area adiacente a Taiwan e, dunque, per limitare la strategia nordamericana di totale controllo del rimland eurasiatico. Le azioni degli Houthi nel Mar Rosso, in questo senso, possono essere interpretate a loro volta come una ulteriore sfida al controllo statunitense dei flussi energetico-commerciali lungo la fascia costiera dell’Eurasia. In altri termini, avendo un impatto che esula dal semplice contesto regionale, le azioni degli Houthi rappresentano una vera e propria sfida alla globalizzazione americana, una sfida dalla quale Russia, Iran e Cina possono trarre non pochi vantaggi.
Tornando al Pakistan, il reale motivo che ha portato alla caduta di Imran Khan, oltre alla sua retorica pregna di certo antioccidentalismo, è stata la sua volontà di tenere una posizione equidistante al momento dell’intervento diretto russo all’interno del conflitto civile ucraino, posizione dettata anche dal rafforzamento delle relazioni commerciali con Mosca. Il giornale investigativo nordamericano “The Intercept” ha citato alcuni “dispacci” fatti pervenire all’ambasciata pakistana, in cui funzionari del Dipartimento di Stato USA si lamentavano per la “neutralità aggressiva” del Pakistan sull’Ucraina e facevano pressioni per rovesciare il governo di Imran Khan[2].
Ciò farebbe rientrare il rovesciamento di Imran Khan (avvenuto tramite il “golpe parlamentare” del 2022) nel novero delle operazioni di “cambio segreto di regime” della CIA. La tattica è ben descritta nello studio di Lindsey O’Rourke dal titolo Covert Regime Change: America’s secret Cold War (Cornell University Press 2018). Qui, la ricercatrice dell’Università di Boston indica ben 64 operazioni di “cambio segreto di regime” attuate dalla CIA tra il 1947-1989 (diverse da quelle più plateali, come il golpe militare in Cile del 1973) e le presenta come una prassi costante utilizzata dagli Stati Uniti per rovesciare governi percepiti come “ostili” o non consoni agli interessi di Washington.
A parziale conferma di questa tesi è arrivata la condanna a dieci anni di reclusione per “spionaggio” e “violazione di segreti di Stato” (sic!) dello stesso Khan nel momento in cui ha rivelato l’esistenza di tali documenti ed in procinto di terminare la sua “lunga marcia”, costellata di manifestazioni oceaniche (e da un attentato alla sua vita), da Lahore a Islamabad.
Appare dunque evidente come il processo elettorale della scorsa settimana sia stato inevitabilmente viziato dalla repressione subita da un Partito che, sotto certi aspetti, esprime i sentimenti profondi di un popolo che in larga maggioranza, soprattutto a causa della disastrosa “guerra al terrore” ed ai bombardamenti reiterati nelle aree tribali, continua a percepire gli USA come un nemico e non un alleato. Non a caso – sebbene il Tehreek-e-Insaf abbia dovuto presentare i suoi candidati da indipendenti e senza simbolo – le elezioni hanno riconfermato il sostegno che il Movimento di Imran Khan gode nel Khyber Pakhtunkwa: area a maggioranza etnica Pashtun (di cui lo stesso Khan è originario per parte di madre) e terza regione più popolosa del Paese. Ma il Tehreek-e-Insaf ha avuto successo anche nel Punjab: l’area più popolosa, storica roccaforte dell’élite militare.
Nel complesso, su 336 seggi dell’Assemblea Nazionale e con un’affluenza alle urne piuttosto bassa (49% su oltre 128 milioni di aventi diritto), i dati ufficiali parlano di 149 seggi attribuiti a candidati indipendenti (99 fedeli a Imran Khan), 87 alla Lega Musulmana guidata da Nawaz Sharif (il fratello, Shehbaz, aveva preso il posto di Khan nel 2022), 53 al Partito Popolare del Pakistan di Bilawal Bhutto Zardari, 12 seggi al Jamiat Ulema-e-Islam del filotalebano Fazal-ur-Rehman (anch’egli sostenitore dell’estromissione di Khan nel 2022), 7 seggi al Muhattida Qaumi Movement (Movimento di Unità Nazionale) di un altro protagonista di lungo corso della politica pakistana Khalid Maqbool Siddiqi (già ministro sotto uno dei tre governi di Nawaz Sharif). Gli ultimi due partiti, nonostante le dimensioni ridotte, hanno un ruolo di primo piano nella scena politica del Paese asiatico. Il JUI rappresenta infatti, almeno in parte, quelle che si potrebbero definire le istanze “islamiste” nella società pakistana; mentre il Partito di Siddiqi (con la sua roccaforte a Karachi) è portavoce dei Muhajiri, ossia di coloro che nel momento della Partizione con l’India migrarono verso il territorio del Pakistan nella convinzione di compiere una “Seconda Egira” verso una “Nuova Medina”.
Alla luce di questi risultati, e nonostante gli appelli “retorici” del già citato capo dell’esercito Munir al “superamento della polarizzazione”, appare chiaro che il prossimo governo sarà il prodotto di un nuovo accordo postelettorale tra i gruppi di potere legati alla famiglia Sharif (arricchitasi negli anni ’80 grazie alla privatizzazione dell’industria dell’acciaio attuata dal regime militare di Zia ul-Haq) e quella Bhutto-Zardari (creata dall’unione tra Benazir Bhutto, figlia di Zulfiqar assassinata nel 2007, e Asif Ali Zardari, ricco imprenditore più volte accusato di corruzione che ha trasformato il PPP in una sorta di comitato d’affari). Nell’ottica dell’Esercito (da sempre diviso tra un’ala filocinese ed una filoamericana che si alternano nel controllo degli apparati di sicurezza), questo governo dovrebbe garantire al Pakistan l’accesso ad un nuovo pacchetto di aiuti economici del Fondo Monetario Internazionale. Un’istituzione in cui – è bene ribadirlo – gli Stati Uniti godono di diritto di veto e che perciò possono utilizzare come strumento di pressione e di ricatto nei confronti di altri Stati. E l’Esercito, in qualità di garante della stabilità del Pakistan, non può permettersi che ciò non avvenga in un momento in cui le istituzioni parallele del sistema BRICS (al cui ingresso il Pakistan ambisce), dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e della Nuova Via della Seta non hanno ancora sviluppato la medesima “potenza di fuoco”.
Dopo tutto, parte del successo del neoliberista, sionista e filoamericano Javier Milei (arrivato, in uno slancio messianico-apocalittico, ad augurare la ricostruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme su suggerimento del suo mentore, il rabbino Axel Wahnish) è dovuta proprio al fatto che l’Argentina rimane dipendente dai salvataggi periodici del Fondo Monetario Internazionale, mentre l’alternativa proposta dai BRICS, anche a causa del ruolo più che ambiguo dell’India, rimane ancora incompleta.
NOTE
[1]Far-right minister says nuking Gaza an option, 5 novembre 2023, www.timesofisrael.com.
[2]Si veda Secret Pakistan cable documents U.S. pressure to remove Imran Khan, 9 agosto 2023, www.theintercept.com.
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.